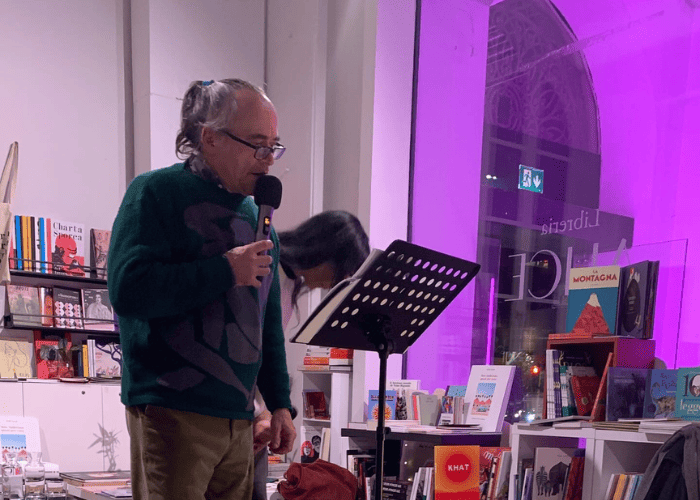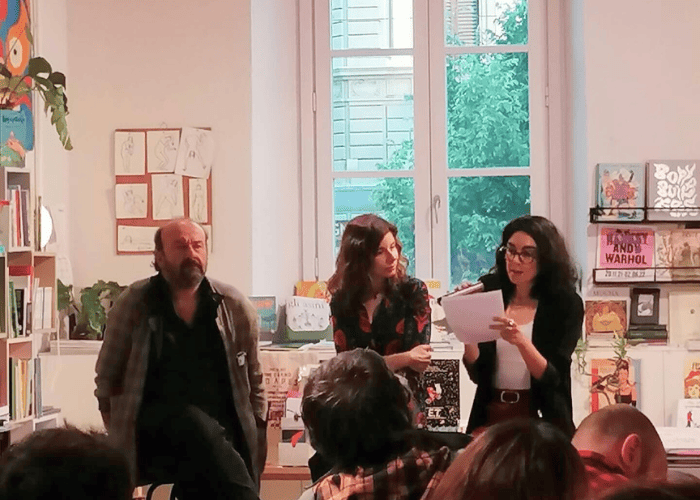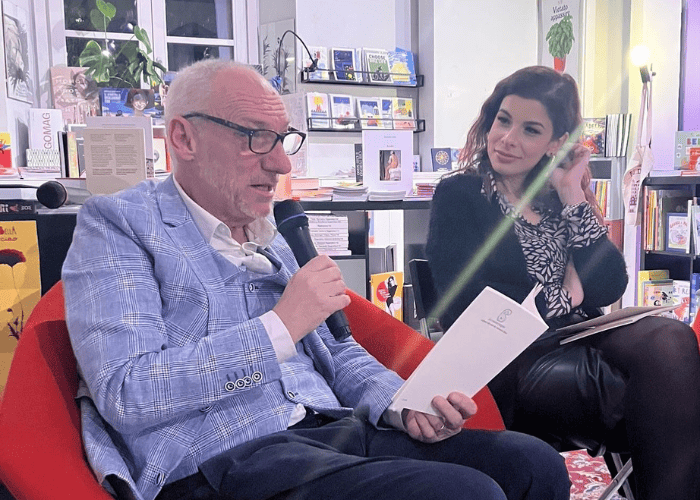Aggiungi qui il testo dell’intestazione
Il poeta Sauro Albisani è nato a Ronta del Mugello nel 1956. Vive a Firenze, dove insegna. Le sue poesie
sono state premiate in alcuni dei concorsi più prestigiosi come Viareggio-Giuria, i premi Pascoli e Carver
e il Premio Gradiva di New York. La sua produzione lirica: Terra e cenere (Il Labirinto, 2002), La valle
delle visioni (Passigli, 2012), Orografie (Passigli, 2014), In bilico (Passigli, 2023).
APOCALISSE 20,13
Compaiono gli squali mentre i naufraghi
aspettavano l’arrivo degli inglesi
aveva vent’anni mio padre
quando lo ripescarono, i più fragili di nervi
cercavano di rituffarsi in mare
(a ottanta divenne
testimone di geova perché
lesse il versetto che dice
il mare restituirà i suoi morti)
IL MALE DELLA BANALITA'
Non è ancora mezzanotte a Gerusalemme.
Eichmann ha chiesto del vino rosso,
e non gli viene dato aceto.
Ha bevuto metà della bottiglia.
Dalla cella al patibolo sono 50 metri,
con le mani legate dietro la schiena.
L’improvvisa fugace rivelazione
di avere già provato quella sensazione
ai polsi, per 56 anni,
subito rimossa, subito annegata
nel laghetto di vino,
nel mare della banalità,
dentro lo stomaco.
Non c’è bisogno del cappuccio nero,
la coscienza
non è autocoscienza.
Tuttavia
vorrei restare in piedi. Per favore
non legatemi troppo strette le caviglie.
Non è ancora mezzanotte a Gerusalemme,
quando Eichmann dice: Io sono un deista.
Ma poi dice anche: Tra breve, signori, ci rivedremo.
Proprio così.
Prima dice: Io sono un deista.
Poi: Tra breve, signori, ci rivedremo.
LA GIOSTRA
Guarda, mi resta ancora qualche spicciolo,
lascia che il cavallino ci trasporti
nelle sue praterie, non ho paura,
a un’ordinotte che la giostra chiude
andremo a casa abbracciandoci stretti
Quanto tempo è trascorso? chiederai
fingendo d’ignorare che d’un tratto
siamo già vecchi
Non fanno rumoregli zoccoli sull’erba, sull’asfalto,
entrano in una nube
Come puòessere così dolce avventurarcidentro l’abisso? vuoi scendere? è troppo,
troppo difficile restare in sella
sui garretti sottili dei cavalli
sospesi in aria
Ci sarà qualcunoche sa dirigere il loro galoppoverso casa?Al giro successivola città è già cambiata
Hai chiuso il gas?
Ho ancora qualche spiccioloHai caricato la sveglia? Domani
prometto resterò per tutto il giorno
con i piedi per terra, se dio vuole.
Ultimo giro, apri gli occhi, guarda
sopra le nuvole, sotto le suole
LASCIATE UN MESSAGGIO DOPO IL BIP
Bisognava chiamare il veterinario.
Quasi all’improvviso il cielo si oscurò
e cominciò il nubifragio.
L’uomo si riparò sotto il gazebo appena in tempo
mentre il cane arrancava verso di lui
strascicando il treno posteriore
sull’erba corta, in pochi attimi
trasformata in un acquitrinio, una palude.
Allungò le braccia fuori dal gazebo
verso le zampe anteriori del cane
e tirò l’animale verso di sé. Fu in quell’istante
che il grande gelso cadde sul prato
inclinandosi all’improvviso e in silenzio,
lentamente,
mentre il muso del cane si alzava
a cercare il suo sguardo. Tranquillo,
sussurrò carezzando il pelo bagnato.
L’odore di orina si era dissolto
nell’odore della terra smossa.
Sentiva da qualche parte un battito di denti:
dovevano essere i suoi, perché il cane
respirava con la bocca aperta.
Sul prato era calato un freddo assurdo
per la fine di maggio, anche questo
così, tutto in un attimo.
Le gocce cadevano tanto violente da sembrare proiettili
sulla tela del gazebo.
I suoi capelli fradici
gocciolavano sul pelo del cane
e sulla sua mano che continuava ad accarezzarlo.
Il cane seguitava a fissarlo,
ma non era come quando gli chiedeva
acqua o cibo. Non restava che aspettare,
aspettare in silenzio.
Guardò la casa vuota,
il cadavere del gelso,
quello sfregio sul prato
come un messaggio lasciato da chi.
Avrebbe voluto chiudere gli occhi.
Ma bisognava chiamare il veterinario
e ora anche il giardiniere.
LE LUCCIOLE SOTTO IL BICCHIERE
Le stringeva nel pugno
le lucciole
(in quel piccolo bugno,
come api)
e pensava:
se apri
le dita, forse
con le ultime forze
voleranno,
tu le potrai vedere
libere.
Ma cedette all’inganno
e sollevò il bicchiere
(sapranno sopravvivere,
chissà!
e fare luce
anche in cattività).
La mamma veglia e cuce
un paio di calzoni.
E’ tardi. A letto!
Il tono
della voce si fissa
nei suoi ricordi. Poi
il buio
il sonno il niente.
Stava imparando che.
Che tanta gente
può anche uccidere
sì, per i soldi.
PESCA NOTTURNA
Accoccolati sullo scoglio, all’una
forse le due di notte, padre e figlio
intirizziti dal salmastro, ubriachi
di quel sonno che (oh, incredibilmente!)
non addormenta ma lascia che l’anima
o la mente o come vuoi chiamarla
salpi sul filo, acrobata nel buio
della perennità del mare; insieme
addormentati e attenti, finalmente
coetanei nel blu, vigili in sogno,
auscultando la mossa…
trepidanti!
…dell’ignoto avversario, che tu ami,
che gli chiedi perdono prima ancora
d’averlo tratto a riva.
(come quando
squilla il telefono: rispondi e, un attimo
prima di riconoscere la voce,
trattieni il fiato… non lo sai chi c’è
dall’altra parte del filo…)
L’UOMO NERO
Se tiro le lenzuola sulla testa;
se di fuori non resta
neanche un lembo del pigiama
arrivo forse a immaginare un mondo,
laggiù, lontano, abitato
solo da gente che mi ama;
che, assurdamente, mi riconosce.
Me lo chiedo ogni volta e non rispondo.
Dio Cristo! domattina
devo uscire, uscirò
prima del solito
per far benzina.
Ma lo so di non essere sincero:
se stringo le lenzuola con i pugni,
no, non dovrebbe farcela ad entrare
qua sotto, l’uomo nero.
NON SAPPIAMO
Mentre spiove dopo il temporale annunciato dalle previsioni
ci guardano muoverci in questo supermercato
pieno di cose quasi tutte superflue,
riempire il carrello di bisogni
anche se sembrerà riempito di merci.
Ci guardano mentre guardiamo senza vederci
(riusciamo a vedere tutto tranne noi stessi, qui dentro)
le leccornie del reparto gastronomico
in questo spazio chiuso dove non sappiamo
di essere guardati non sappiamo da chi
non sappiamo perché.
Fuori intanto è tornato il sole.
LARI
Caro lettore, ho cambiato casa.
Da bambino studiavo Api vivente,
il dio egizio, alle elementari.
Nella stalla
ruminavano i buoi. Io in silenzio
m’avvicinavo alla sua mangiatoia.
M’interessava l’occhio
grande come il mio viso, un pianeta.
Mi guardava, il dio della pazienza,
allungare le mani,
e non smetteva mai di ruminare:
un dio, un dio mi entrava nella mente
scacciando mosche e tafani
con la coda,
ritmicamente.
Non c’è posto, lettore, per i libri
nella mia nuova casa.
Anche nei libri cercavo qualcuno,
non ricordo più chi,
non torna a galla.
Ho sistemato i libri nella stalla.
La mangiatoia è uguale
a quella che riempivo d’erba fresca.
Provo a chiudere gli occhi.
Ora allungo la mano, titubante,
senza sfiorare la pupilla.
Non so cosa cercavo dentro i libri.
Sono pesanti, polverosi.
Cosa cercavi,
continuo a domandarmi sorridendo.
E non vola una mosca
mentre poso la biro.
Da qualche parte
dentro un sussidiario
c’è ancora il dio Api.
Il suo respiro.
His soul goes marching on
Il bambino portava al doposcuola
un panierino azzurro. La merenda
era una fetta di pane col burro
e lo zucchero. Diciotto anni prima
era finita la guerra mondiale.
Non lo sapeva ancora. Le maestre
cantano Glory! Glory! Hallelujah!
Bambini, insieme, ripetete in coro.
La mamma cuce i pantaloni. Lui
pensa al paese, e canta, è solo un mese
che sta in città. Si vergogna di togliere
quella fetta di pane dal paniere.
Glielo fanno pesare, che è un ragazzo
venuto dal paese. Forse è solo
il primo mese, poi saranno amici.
Si fa che s’era: io, il padrone,
e tu lo schiavo; cominciamo adesso.
John Brown’s body lies a-moulderling in the grave.
E’ iniziata la terza elementare.
Lui non ha fame e non sa cantare.
PASSWORD
Pietro, ricordi ancora il pomeriggio
delle “Donne curiose”? Era iniziata
la primavera, a scuola si faceva
la prova generale per la recita
di fine anno. Eri mingherlino
nelle culottes settecentesche, bravo
più del primo, tu, ultimo o quasi,
della classe. Con quel cognome veneto
che non dico, con quel sorriso mite
che sembrava ripetere scusate,
mi dispiace, non so, non so perché.
Non so perché, proprio la stessa password
che ho messo nel computer: mi dispiace.
Significa ho paura… mi daranno
il benvenuto? Riconosceranno
il mio nome fra tanti, uguaile a tanti?
Io ti riconoscevo di lontano:
eri il più basso di statura, in mezzo
ai tuoi compagni, e quando rispondevi
la cosa giusta il tono della voce
era quello di chi sa di sbagliare
con un presentimento di sorriso
sulle labbra socchiuse, involontario.
Tu recitavi male, ed era bello
vederti recitare: eri vero,
eri tu, in quei panni non tuoi, eri
il più sincero. Pietro, ti ricordi
di me? Che fai? sono il tuo professore,
che (molto prima) ti ha voluto bene,
prima di quella notte che hai cercato
la risposta ai perché nelle tue vene.
DOPPIO SELFIE
Allo specchio il mio volto
mi dice: io. Però
chi sono io che l’ascolto?
Non lo so.
ALI
Di quelle rare volte
che un pensiero è arrivato
intrufolandosi
nella mia stanza gelida,
lasciando sopra il vetro
della finestra chiusa
una traccia di piume.
Non ero solo, chino
sul mio quaderno, al lume
della lampada, mentre
di là tutti sognavano.
Non sono solo.
Qualcosa si è staccato
da un mondo prossimo, invisibile,
e ha preso il volo.
La linguista Caterina Canneti è nata a Firenze nel 1990, è attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze. Ha collaborato con l’Accademia della Crusca ed è docente di Lettere alla scuola secondaria di primo grado.
Il titolo: “In bilico”, riflessioni sul significato e sull’etimologia di ‘bilico’
Bilico: dal vocabolario Treccani emergono due significati: uno legato all’ambito spaziale (“posizione di equilibrio instabile”) e un altro legato all’emotività (“stato dubbioso, incerto”).
Il termine bilico è connesso al verbo bilicare, del quale, nel GDLI, si rintracciano specifici significati, legati anche ad attestazioni letterarie (Pulci = trans., ‘colpire nel centro’; Fagiuoli = figur., ‘ponderare, riflettere’; ant. ‘girare
intorno al bilico’). Bilicare, inoltre, proviene dal latino umbilicare, che condivide la stessa etimologia di umbilicus, ‘ombelico’, dunque con qualcosa che si connette all’origine, all’inizio della nostra vita (l’ombelico è ciò che resta del cordone ombelicale, una traccia della nostra nascita, dell’inizio del nostro tempo).
Osservazioni linguistiche generali, il lessico
- Uso maggioritario di un registro quotidiano, antiretorico; Quasi totale assenza di metrica e sporadicità di figure retoriche;
- Mancato ricorso alle maiuscole e alla punteggiatura, anche in presenza di inserti dialogici;
- Flusso di coscienza: il testo scorre e segue il flusso dei pensieri del poeta.
- Grande varietà di lessico:
Forestierismi: I care, His soul goes marching on, goal, trench, Where are you from?, près de midi, tie-break, matchball, net, backup, browser, database, chip, trap…
Dialettismi/Regionalismi: gralime (dal Rigutini-Fanfani 1875: fior. Plebeo, metatesi g/l), si fa che s’era, fo (‘io faccio’), gote, babbo, ruzzo…
Abbreviazioni e marchionimi: coop, penna bic…
Tecnicismi settoriali: tachicardia, dna, prima persona plurale, nome proprio, sillaba, postulare, interurbana…
Linguaggio poetico: vecchiezza, quiete, vagito, garrula, dolce fanciulla, detestata soglia, evitar non impetro (impetrare è latinismo), lodoletta (‘allodola’), leggiadre smorfie, palpito…
Termini ed espressioni latine: Aut Aut (cfr. Kierkegaard), funere mersit acerbo, lux perpetua luceat ei, ars moriendi, fons perennis, miserere, iacta est, alter ego, sicut in terra, spes amissa…
Riflessione sul neologismo “logoforo“, come termine che rappresenta il ruolo che Albisani conferisce al poeta in quanto ‘portatore di parole’, dunque colui che produce parole con la sua poesia, ma che contemporaneamente, come poeta, è creato dalla sua stessa poesia.
L’importanza del tempo nella poesia di Sauro Albisani
Il tempo è un elemento molto presente nella raccolta, non soltanto dal punto di vista del contenuto, ma anche da quello della lingua. Nelle poesie, infatti, sono molti i riferimenti lessicali allo scorrere del tempo (indicazioni di età e durata, di momenti specifici della giornata; avverbi di tempo e locuzioni temporali).
Tempi verbali: molto usato il passato (il tempo del ricordo, soprattutto in riferimento all’infanzia), che spesso si alterna col presente anche nella stessa poesia; uso del presente storico, quando si narrano vicende di specifici personaggi; uso del futuro nel momento in cui il poeta si riferisce alla realtà, a qualcosa che promette di fare, anche se forse sa già di non poter mantenere una promessa di realtà. Uso prevalente della prima e della terza persona, talvolta in alternanza nello stesso testo (data la presenza di inserti dialogici).
Importanza del ricordo, anche a livello lessicale
FAMIGLIA, CASA E DIMENSIONE AFFETTIVA: padre, casa, figlio, mamma che cuce i pantaloni
ABISSO, PAURA, MORTE: morte/morti, patibolo, mare, cappuccio nero, annegata, abisso, paura, oscurarsi, naufragare, buio, sonno, niente, perennità del mare…
NON SAPERE, NON CONOSCENZA: ignoto, lo so, non sappiamo, non ricordo, non lo sapeva ancora, non so perché.
SPIRITUALITà E RELIGIONE: testimone di Geova, versetto, deista, dio (sempre con lettera minuscola), messaggio, dio egizio, mangiatoia, dio della pazienza…